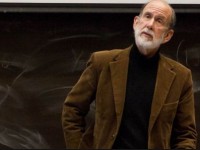A più di 30 anni dalla sua tragica morte e dopo decenni di oblio, da più parti oggi assistiamo, non senza un certo disgusto, alla corsa, da parte dei più abili trasformisti della politica italiana, alla rivalutazione della figura di Berlinguer. Ricordo dello storico dirigente del PCI al netto delle mistificazioni.
di Dino Greco
Nel corso del 2014 abbiamo assistito, da parte della cosiddetta sinistra del Partito Democratico (cioè della parte di esso lì transumata, di mutazione in mutazione, dal PCI), ad una singolare riesumazione, dopo trent’anni di rimozione e di oblio, della figura di Enrico Berlinguer. Un cimento a cui non si può non guardare con irritazione, considerata la totale estraneità del Pd renziano, ma non solo, alla storia, alla cultura, alla concezione della politica che furono del grande dirigente comunista e del suo partito. Per non parlare del processo degenerativo e corruttivo della politica che, per una sorta di contrappasso dantesco, ora coinvolge e travolge interi strati del gruppo dirigente democratico.
Si è, tuttavia, trattato di una riappropriazione indebita, compiuta nell’intento di lucrare su alcuni tratti politici dell’ultimo vero segretario del PCI, attraverso un’operazione che sta a metà fra la millanteria e la contraffazione. Ma mettiamo indietro le lancette e proviamo a ricordare. Fu Pietro Fassino, già segretario dei Democratici di Sinistra, a bollare Berlinguer, dopo la sua morte, come “passatista e fallito”, di fronte ad un Craxi definito “modernizzatore e vincente”. Il segretario post-comunista leggeva nella morte di Berlinguer su quel palco di Padova la metafora del “giocatore di scacchi che ha capito, prima che la partita finisca, che la sconfitta è inevitabile, e a cui rimane solo di morire prima dell’ultima mossa”. Toccò poi a Walter Veltroni, anch’egli segretario dei post-comunisti trasfiguratisi, di metamorfosi in metamorfosi, in Partito Democratico, a chiarire di “non essere mai stato comunista” e che “comunismo e libertà sono incompatibili”. Ci si mise poi con impegno la giornalista Miriam Mafai, autrice, nel 1996, di un molto reclamizzato libello dall’eloquente titolo “Dimenticare Berlinguer”, un testo che ebbe molta fortuna fra post-comunisti, a-comunisti e anti-comunisti (del resto il confine fra gli uni e gli altri è diventato esile come un foglio di carta velina). Qui vi si sosteneva che la definitiva sepoltura ideale e politica del segretario comunista era necessaria per sbloccare la sinistra, liberarla dalle proprie catene ideologiche e accreditarla come affidabile forza di governo. Quello scritto aveva un solo – e per altro involontario – pregio e cioè quello di riconoscere che Berlinguer era pienamente inscrivibile nella tradizione comunista e che, proprio in ragione di questo suo inestinguibile profilo politico, doveva essere per sempre tumulato, senza alcuna nostalgia.
Ma l’attacco a Berlinguer non è certo iniziato post-mortem. Già col XVIII congresso, nel 1989, Achille Occhetto, divenuto segretario del PCI, gettava le basi di questa operazione “palingenetica”: nella sua relazione d’apertura scompariva ogni riferimento alla Rivoluzione d’Ottobre, sostituito dalla Rivoluzione francese, Togliatti diventava “l’incolpevole complice di Stalin”, la “Terza via” al socialismo veniva archiviata come un’aporia, la “diversità comunista” non era più che un guscio vuoto di cui liberarsi. Più in profondità, veniva meno l’idea del socialismo come formazione economico-sociale distinta ed opposta rispetto al capitalismo. La dissoluzione dell’Unione Sovietica, il crollo del muro di Berlino, agiscono come un detonatore su una parte cospicua del gruppo dirigente del PCI che aveva da tempo in incubazione la propria Bad Godesberg, ed Occhetto ne interpreta perfettamente umori e tendenza. Di tanta furia iconoclasta si accorse e si preoccupò – come ricorda Lucio Magri nel suo Il sarto Di Ulm – persino un vecchio e autorevole liberale come Norberto Bobbio, che scrisse su La Stampa: “Mi domando se ciò che avviene nel Pci non sia una vera inversione di rotta”. Ormai il “nuovo corso” era tracciato: smantellare la diversità comunista e fare crollare la conventio ad excludendum, dunque: abiura & rimozione, senza analisi critica. Si tratta di quel fenomeno cui si riferiva lo psicanalista Cesare Musatti quando, nel suo Chi ha paura del lupo cattivo (Editori riuniti), descriveva l’atteggiamento dello sconfitto che per superare l’insopportabilità dello scacco, assume il punto di vista dell’avversario e, armi e bagagli, salta sul carro del vincitore: una vera e propria – come la definì Gustav Jung – “fuga nell’opposto”.
Lucido e carico di amara ironia, il commento di Mario Tronti: “Non eravamo più comunisti da tempo e adesso possiamo dirlo con un gran respiro di sollievo, così gli altri ci riconosceranno come loro simili e noi, senza quel nome, non saremo più in contraddizione con la bella realtà che ci circonda”. Infine, ma non certo da ultima, la frustata caustica di quelle donne comuniste che, partendo dall’esperienza da esse compiuta in quegli anni, avevano scoperto l’essenzialità della coscienza di sé: “L’anticomunismo dei post-comunisti è come la misoginia delle donne, perché contiene il rifiuto, la rimozione, il disconoscimento della propria identità.”
Ma l’operazione più fraudolenta contro Berlinguer, in pieno dispiegamento ai giorni nostri, è la sterilizzazione del suo pensiero, per cui di lui si ricorda essenzialmente che era “una brava persona”, quasi un santo, in mezzo ad un mondo di corrotti, di lestofanti, di malversatori: un’icona, insomma, da portare in giro come la Madonna pellegrina. Così la stessa questione morale viene ridotta a moralismo e spogliata di ogni portata politica. L’ultimo e più recente esempio di contraffazione lo offre l’intervista di Walter Veltroni a Giorgio Napolitano, comparsa sul ponderoso inserto che L’unità ha dedicato a Berlinguer nel trentennale della sua scomparsa. “Cosa diresti – chiede Veltroni – ad un ragazzo che non l’ha conosciuto, com’era Berlinguer?” Napolitano risponde: “La politica come vocazione”. Una definizione diametralmente opposta a quella che diede di sé Berlinguer medesimo, interrogato dal giornalista Minoli circa le ragioni che lo avevano indotto a compiere la scelta dell’impegno politico. In sostanza, e come vedremo meglio più avanti, l’obiettivo tenacemente perseguito dai dirigenti del Pd è quello di cancellare il Berlinguer comunista e rivoluzionario, che tale rimase fino all’ultimo.
Parlare oggi di Berlinguer significa, dunque, restituire a lui e al PCI, senza cadere nell’agiografia, il valore di una storia da cui c’è ancora molto da imparare. Cominciando con le parole (“rivoluzione”, “fuoriuscita dal capitalismo”, “classe operaia”, “lotta di classe”, “comunismo”) che Berlinguer usava sempre (e per lui le parole erano davvero pietre) senza alcuna ridondanza o concessione retorica ma per il loro intimo significato; non come ultimo residuo feticcio identitario ma come concetti vitali nella ricerca aperta, mai dogmatica, di ispirazione marxiana e gramsciana, di una via per la rivoluzione in Occidente. Una via diversa sia dal socialismo sino allora realizzato, sia dalle socialdemocrazie. Questo spiega il suo fecondo rapporto con i capi delle sinistre socialdemocratiche svedese e tedesca, Olof Palme e Willy Brandt.
C’è un tratto raro della personalità di Berlinguer che merita sottolineare: lui faceva capire a chi lo ascoltava una cosa tanto essenziale quanto desueta fra gli odierni politicanti e cioè che credeva davvero in ciò che diceva. Come ebbe a ricordare Gian Carlo Pajetta, “Berlinguer parlava esattamente nello stesso modo a Pechino come a Mosca”. Ci sono due date e altrettanti passaggi fondamentali che descrivono, anche sotto il profilo teorico, il percorso che porta alla piena autonomia del Partito comunista italiano dal Pcus: il 1969, a Mosca, nella Conferenza internazionale dei partiti comunisti e operai, quando Berlinguer respinge la teoria del “partito guida” e dell’uniformazione dei modelli di socialismo a quello sovietico, rivendicando il multipolarismo e difendendo l’originalità della via italiana al socialismo; e il 1977, sempre a Mosca, in occasione del 60° anniversario della Rivoluzione d’Ottobre, quando Berlinguer afferma con grande forza il concetto del valore universale della democrazia come elemento consustanziale al socialismo, rendendo palese la critica severa alle forme di socialismo realizzate che non hanno saputo pienamente svilupparsi nel rispetto della libertà, del pluralismo politico, della democrazia. Si tratta, a ben vedere, dell’idea gramsciana della rivoluzione come mutamento dei rapporti di produzione, come superamento del modo capitalistico di produzione, ma anche come grande riforma intellettuale e morale, come superamento del rapporto gerarchico fra governanti e governati. C’è in Berlinguer un evidente sforzo creativo. Egli si rifà, precisamente, alla nozione gramsciana di guerra di movimento e guerra di posizione: l’una resasi possibile nella Russia arretrata (“dove lo Stato è tutto e la società civile gelatinosa”), l’altra necessaria in Occidente (“dove nel tremolio dello Stato si intravvede una catena di robuste casematte”). Ma Berlinguer non perde mai di vista che l’obiettivo di entrambe le strategie è la radicale trasformazione dei rapporti sociali, il superamento del modo capitalistico di produzione e di scambio, l’abolizione dello sfruttamento e la costruzione di una società fatta di liberi ed eguali. Certo, c’è la denuncia, fortissima e preveggente, – se pensiamo a ciò che è diventata l’Italia odierna – dello stato di decadimento e di grave compromissione dei partiti e di degenerazione della democrazia, come sottolineano le parole che Berlinguer consegnò ad Eugenio Scalfari nella notissima intervista del luglio 1981. Tuttavia, attenzione: pulire il Paese dalla corruzione, dall’occupazione dello Stato da parte dei partiti, è per Berlinguer premessa necessaria ma non sufficiente, perché poi ci sono i contenuti dell’azione rivoluzionaria. Siamo nel 1977, dopo le due grandi avanzate elettorali (le amministrative del ’75 e le politiche dell’anno successivo) che portano il PCI oltre il 34% e oltre i 12 milioni di voti. Berlinguer promuove, a 15 giorni di distanza l’una dall’altra, due iniziative: un convegno rivolto agli intellettuali italiani, presso il Teatro Eliseo di Roma, e la conferenza nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori comunisti, presso il Teatro Lirico di Milano. Ebbene, agli intellettuali come agli operai, esattamente negli stessi termini, Berlinguer pone una questione di primaria grandezza che si può così riassumere: a questo punto della nostra forza non possiamo occuparci soltanto della redistribuzione della ricchezza che pure rimane un cimento irrinunciabile; “il tema che è maturo sotto la pelle della storia è come, cosa produrre e per chi” e lo svolgimento di questo tema è più che mai nelle mani dei produttori, della classe operaia e delle forze intellettuali riunite intorno ad essa.
In definitiva, la questione posta è che non si può rimanere imprigionati nel recinto dei rapporti sociali dati che ormai rappresentano – marxianamente – catene per l’ulteriore sviluppo delle forze produttive. Per promuovere un nuovo incivilimento occorre intaccare i rapporti di produzione e il modello capitalistico di accumulazione. La questione del potere si pone sì, ma non come occupazione dello Stato da parte di un partito bensì come profondo rinnovamento delle classi al potere, dei fini e dei metodi di governo. Perché ciò avvenga – aggiunge Berlinguer – “è necessario un intervento innovativo nell’assetto proprietario” nel sistema delle imprese. Quello che Berlinguer pone all’ordine del giorno è un nuovo livello dell’egemonia del proletariato. E’ del tutto evidente che, qui, Berlinguer prende per le corna il tema cruciale della transizione verso il socialismo. E lo fa sia dal lato dei consumi (umanamente ricchi), contro il consumismo, sia dal lato della produzione, contro l’acefala produzione di merci che ha come unica bussola il profitto privato.
Berlinguer porta, dunque, la riflessione politica ad un livello, mai raggiunto prima, di comprensione del processo sociale e del ruolo storico della classe operaia verso la costruzione di una società in cui i produttori associati, riuniti in libere e democratiche istituzioni, possano davvero promuovere il proprio autogoverno e divenire protagonisti del proprio destino.
Questa proposta politica sarà duramente osteggiata, fuori e dentro il partito, da destra e da sinistra. L’accusa sarà quella di “pauperismo”, di “ascetismo” a cui Berlinguer replicherà, a muso duro, proprio nella conferenza operaia.
Nella storiografia comunista si è spesso parlato di “due Berlinguer”, quello del “compromesso storico” e quello che dopo la rottura della solidarietà nazionale, rompe duramente con la DC e imprime al Partito Comunista una netta svolta a sinistra. Chi scrive pensa che questa lettura soffra di schematismo manicheo. Certo, vi fu una cesura, e assai netta, fra le due stagioni politiche. Ma al centro della riflessione politica e teorica di Berlinguer vi fu, nell’una come nell’altra fase, la scelta di quella che egli riteneva la strada migliore e la più produttiva per portare ad un livello più favorevole e più alto la lotta per la trasformazione dell’ordine di cose esistente, in direzione del socialismo. E quando Berlinguer si accorse che la strategia del ’compromesso storico’ portava in un cul de sac, fu proprio lui il critico più spietato di se stesso e di quella linea politica.
L’errore, nel fuoco del golpismo e del terrorismo che infuriava in quegli anni, fu quello di ritenere possibile, per così dire, una democratizzazione, una ‘costituzionalizzazione’ della Democrazia Cristiana, sopravvalutando il ruolo che in essa potesse/volesse svolgere Aldo Moro. E, più ancora, ritenendo possibile un affrancamento della borghesia industriale italiana dal proprio storico sovversivismo, dalla propria inclinazione tendenzialmente reazionaria, così da poterla piegare ad un compromesso stabile con le conquiste operaie che, al contrario, essa stava duramente mettendo in discussione. Errori gravi, che Berlinguer riconobbe esplicitamente e senza sconti per se stesso.
La svolta impressa da Berlinguer è molto netta e ne sono emblematica espressione due vicende. La prima, nel 1980, di fronte ai licenziamenti intimati dalla Fiat a 14 mila operai, quando Berlinguer decide di andare davanti ai cancelli della fabbrica simbolo del capitalismo italiano per dichiarare ai lavoratori che presidiano lo stabilimento, nell’epica lotta dei 35 giorni, che il Partito Comunista sarà al loro fianco qualunque sia la forma di lotta che essi decidano di adottare. E la seconda, nel 1982, quando reagirà nel modo più duro di fronte alla decisione del governo Craxi di tagliare tre punti di scala mobile. Di fronte ad una Cgil spaccata e molto incerta nella stessa leadership di Lama, Berlinguer metterà in campo tutta la forza del Pci per contrastare un attacco frontale alla classe operaia italiana. Lo scontro nel gruppo dirigente del PCI è ormai acuto. A Berlinguer non si perdona l’abbandono della linea della “solidarietà nazionale” e la durissima critica al partito socialista di Craxi. L’attacco al segretario, nella Direzione del partito, si fa aspro e altrettanto lo è la replica di Berlinguer. Nel dicembre del 1981 il segretario, con un lungo articolo pubblicato sul settimanale Rinascita, va all’attacco dei presunti “rinnovatori”. Il titolo “Rinnovamento della politica e rinnovamento del PCI” rappresenta, nel modo più esplicito, il trasferimento dello scontro da tempo deflagrato nel gruppo dirigente nella dimensione pubblica. Tutto il partito, fino all’ultimo iscritto, deve conoscere la natura politica del confronto che è aperto, decisivo per il futuro del più grande partito comunista dell’Occidente. E questo Enrico Berlinguer lo dice, apertisverbis anche rivolgendosi direttamente al suo partito, ai suoi militanti con parole nettissime, che rendono chiaro il livello dello scontro apertosi nel gruppo dirigente del PCI. Per la prima volta è in gioco la leadership di Berlinguer. E per la prima volta Berlinguer parla della possibilità di ritirarsi. Lo fa pubblicamente, con una vena di inedita rudezza, nel corso di una Tribuna politica del 1982:
Se poi io abbia ancora le forze, le energie per continuare a ricoprire la responsabilità che ho, questa è una questione che esiste e sulla quale discuteranno certamente gli organi dirigenti e sulla quale avrò anch’io la mia parola da dire.
Come ognuno sa, Berlinguer terminò la sua battaglia da combattente, quale è stato per l’intera sua vita, su quel palco di Padova. Il PCI sospese allora la campagna elettorale per le europee. Pochi giorni dopo, il risultato delle urne fu che il Partito Comunista era diventato il primo partito d’Italia. Si parlò di un risultato dettato dall’emozione. Ma l’osservazione è grottesca, se non altro perché – parafrasando Rousseau – “solo alle anime grandi” è dato di suscitare emozioni di questa intensità.
Gli operai della Fiat di Torino, in quella insuperabile manifestazione di dolore e di orgoglio comunista che furono i funerali di Berlinguer, portarono uno striscione su cui era scritto: “Siamo venuti per ricambiare quello che hai fatto per noi”. Nessuno, da allora, ha più saputo meritare tanto.
Ma da lì ha preso avvio un’altra vicenda che avrebbe divelto fino all’ultimo caposaldo – culturale, teorico, politico – di quella grande storia, fino alla miserabile nullità della politica odierna.


 28 Giu 2015
28 Giu 2015
 Posted by Iskra
Posted by Iskra