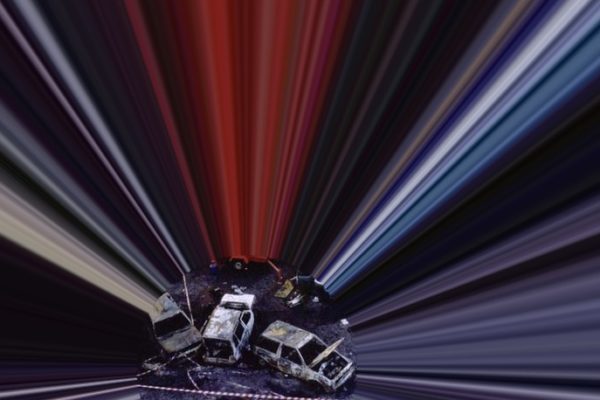Depositate le motivazioni della sentenza: “disegno criminoso degli investigatori”
di Aaron Pettinari
“Le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino sono state al centro di uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana” e “soggetti inseriti negli apparati dello Stato” indussero il balordo della Guadagna, Vincenzo Scarantino, a rendere false dichiarazioni sulla strage che, cinquantasette giorni dopo “l’Attentatuni di Capaci”, uccise il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Eddie Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Claudio Traina.
E’ questo uno dei passaggi delle motivazioni della sentenza del cosiddetto Borsellino quater che, a distanza di un anno e due mesi dalla pronuncia del dispositivo, è stata depositata nel tardo pomeriggio di ieri dai giudici della Corte d’assise di Caltanissetta. Un totale di 1856 pagine in cui il Presidente Antonio Balsamo e il giudice a latere Janos Barlotti spiegano perché si è giunti alla condanna all’ergastolo per i boss Salvo Madonia e Vittorio Tutino e a dieci anni per calunnia i falsi pentiti Francesco Andriotta e Calogero Pulci. Il giorno della sentenza era stato dichiarato “non doversi procedere per pervenuta prescrizione in ordine al reato di calunnia pluriaggravata” nei confronti di Vincenzo Scarantino in quanto, in base all’attenuante dell’art.114 terzo comma, veniva riconosciuto che il “pupo vestito” (come egli stesso si definiva) aveva effettuato la calunnia perché “determinato a commettere il reato”.
I giudici, nelle motivazioni della sentenza, parlano di “suggeritori” esterni, soggetti che avrebbero cioè imbeccato il falso pentito inducendolo a mentire. “Soggetti, – scrivono – i quali, a loro volta, avevano appreso informazioni da ulteriori fonti rimaste occulte”.
Il depistaggio Scarantino
Quel depistaggio, costato la condanna all’ergastolo a sette innocenti poi scarcerati e scagionati nel processo di revisione, viene indicato dalla Corte come “un proposito criminoso determinato essenzialmente dall’attività degli investigatori, che esercitarono in modo distorto i loro poteri”.
Proprio sul gruppo degli investigatori dell’epoca, guidato da Arnaldo La Barbera (deceduto), vengono accesi i riflettori. Secondo i giudici sarebbero stati loro a indirizzare l’inchiesta costruendo i falsi pentiti e la motivazione non si sarebbe celata dietro un’ansia di ottenere risultati nella ricerca dei responsabili del delitto del 19 luglio 1992. Lo Scarantino viene infatti definito come “un soggetto psicologicamente debole che era rimasto per un lungo periodo di tempo (quasi un anno e nove mesi) in stato di custodia cautelare proprio a seguito delle false dichiarazioni rese dal Candura sul suo conto, ed era stato, frattanto, oggetto di ulteriori propalazioni, parimenti false, da parte dell’Andriotta, il quale millantava di avere ricevuto le sue confidenze durante la co-detenzione. Egli quindi, come ha evidenziato il Pubblico Ministero, aveva ‘maturato la convinzione che gli inquirenti lo avessero ormai ‘incastrato’ sulla scorta di false prove'”. Secondo la Corte dopo un lungo periodo nel quale lo Scarantino aveva professato inutilmente la propria innocenza, le sue residue capacità di reazione vennero infine meno a fronte dell’insorgenza del proposito criminoso portato avanti da quegli investigatori.
Così furono compiute “una serie di forzature, tradottesi anche in indebite suggestioni e nell’agevolazione di una impropria circolarità tra i diversi contributi dichiarativi, tutti radicalmente difformi dalla realtà se non per la esposizione di un nucleo comune di informazioni del quale è rimasta occulta la vera fonte”.
Il falso mescolato assieme a un po’ di vero
La Corte dedica una parte delle motivazioni anche a quelle dichiarazioni dello Scarantino che, “pur essendo sicuramente inattendibili, contengono elementi di verità”. “Sin dal primo interrogatorio reso dopo la manifestazione della sua volontà di ‘collaborare’ con la giustizia, in data 24 giugno 1994 – scrivono i giudici – lo Scarantino ha affermato che l’autovettura era stata rubata mediante la rottura del bloccasterzo, e ha menzionato l’avvenuta sostituzione delle targhe del veicolo. Nel successivo interrogatorio del 29 giugno 1994 egli ha specificato che, essendo stato rotto il bloccasterzo dell’autovettura, il contatto veniva stabilito collegando tra loro i fili dell’accensione. Nelle sue successive deposizioni, lo Scarantino ha sostenuto che la Fiat 126 era stata spinta al fine di entrare nella carrozzeria (circostanza, questa, che presuppone logicamente la presenza di problemi meccanici tali da determinare la necessità di trainare il veicolo). Egli, inoltre, ha aggiunto di avere appreso che sull’autovettura erano state applicate le targhe di un’altra Fiat 126, prelevate dall’autocarrozzeria dello stesso Orofino, e che quest’ultimo aveva presentato nel lunedì successivo alla strage la relativa denuncia di furto”. Ebbene tutte queste circostanze sono “del tutto corrispondenti al vero ed estranee al personale patrimonio conoscitivo dello Scarantino, il quale non è stato mai coinvolto nelle attività relative al furto, al trasporto, alla custodia e alla preparazione dell’autovettura utilizzata per la strage”. Queste circostanze, che saranno anche raccontate da Gaspare Spatuzza (l’ex boss di Brancaccio che si è autoaccusato del furto dell’auto, ndr), come potevano essere note dai cosiddetti suggeritori? Secondo i giudici “E’ del tutto logico ritenere che tali circostanze siano state a lui suggerite da altri soggetti, i quali, a loro volta, le avevano apprese da ulteriori fonti rimaste occulte”.
Le note del Sisde
Ma come si arrivò a Scarantino? Nel corso del processo vennero riscontrate alcune anomalie come ad esempio l’appunto con cui, in data 13 agosto 1992, il Centro Sisde (il servizio segreto civile) di Palermo comunicò alla Direzione di Roma del Sisde che “in sede di contatti informali con inquirenti impegnati nelle indagini inerenti alle recenti note stragi perpetrate in questo territorio, si è appreso in via ufficiosa che la locale Polizia di Stato avrebbe acquisito significativi elementi informativi in merito all’autobomba parcheggiata in via D’Amelio, nei pressi dell’ingresso dello stabile in cui abitava la madre del Giudice Paolo Borsellino. (…) In particolare, dall’attuale quadro investigativo emergerebbero valide indicazioni per l’identificazione degli autori del furto dell’auto in questione, nonché del luogo in cui la stessa sarebbe stata custodita prima di essere utilizzata nell’attentato”. La Corte, così come i pm, ricorda che in quella data ancora non era comparso sulla scena Candura, “prima fonte dell’accusa nella direzione della Guadagna”. Chi era dunque il soggetto a cui si riferisce la nota?
“Quale fosse tale fonte nessuno ha saputo o voluto rivelarla – annotano i giudici – Residua allora il dubbio che gli inquirenti tanto abbiano creduto a quella fonte, mai resa ostensibile, da avere poi operato una serie di forzature per darle dignità di prova facendo leva sulla permeabilità di un soggetto facilmente ‘suggestionabile’, incapace di resistere alle sollecitazioni, alle pressioni, ricattabile anche solo accentuando il valore degli elementi indiziari emersi a suo carico in ordine alla vicenda di Via d’Amelio o ad altre precedenti vicende delittuose (in particolare alcuni omicidi) con riguardo alle quali egli era al tempo destinatario di meri sospetti”.
La Corte parla anche dell’iniziativa, definendola “decisamente irrituale”, presa dall’allora procuratore di Caltanissetta Tinebra di chiedere la collaborazione nelle indagini di Bruno Contrada, all’epoca numero tre del Sisde, poi arrestato per mafia dai pm di Palermo nel dicembre del 1992, già nel giorno immediatamente successivo alla strage di Via D’Amelio. In tal senso va sottolineato come la normativa vigente all’epoca, ancor già tenuto conto che Contrada non rivestiva la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, precludesse al personale dei servizi di informazione e sicurezza di intrattenere rapporti diretti con la magistratura. E i giudici non possono fare a meno di rilevare che quella richiesta fece seguito alla “mancata audizione del dottore Borsellino nel periodo dei 57 giorni intercorso tra la strage di Capaci e la sua uccisione, benché lo stesso magistrato avesse manifestato pubblicamente la propria intenzione di fornire il proprio contributo conoscitivo, nelle forme rituali, alle indagini in corso sull’assassinio di Giovanni Falcone, cui egli era legato da una fraterna amicizia”.
La Corte ricorda “la particolare attenzione rivolta allo Scarantino dai servizi di informazione, nei mesi immediatamente successivi alla strage”, così come dimostrato in alcuni documenti segnalati già nella sentenza del “Borsellino uno”. Vi è un informativa riservata del Sisde, trasmessa alla Squadra mobile il 10 ottobre 1992, nella quale si segnalavano i rapporti di parentela e affinità di taluni componenti della famiglia Scarantino con esponenti delle famiglie mafiose palermitane, i precedenti penali e giudiziari rilevati a carico dello Scarantino Vincenzo e dei suoi più stretti congiunti.
La Corte ricorda il dato che il Capo della Squadra mobile, Arnaldo La Barbera, aveva già intrattenuto un rapporto di collaborazione “esterna” con il Sisde (dal 1986 al marzo 1988), con il nome in codice “Rutilius”, mentre dirigeva la Squadra Mobile di Venezia, ma la Corte evidenzia che già nel periodo immediatamente anteriore alla trasmissione alla Squadra Mobile di Caltanissetta della suddetta nota del Sisde relativa allo Scarantino, quest’ultimo era stato destinatario di una intensa attività investigativa.
Candura-Andriotta
La Corte mette in fila i colloqui investigativi che i funzionari di polizia avranno con Salvatore Candura, Francesco Andriotta e Vincenzo Scarantino. Scrive la Corte che “è rimasto documentalmente confermato che la falsa collaborazione con la giustizia fu preceduta da colloqui investigativi di entrambi con il Dott. La Barbera, e del primo anche con il Dott. Bo’. Un colloquio investigativo del Dott. La Barbera precedette anche un successivo interrogatorio dell’Andriotta contenente un significativo adeguamento al racconto – parimenti falso – esposto dal Candura. A sua volta, il Dott. Ricciardi effettuò un ulteriore colloquio investigativo che precedette un consistente mutamento del contributo dichiarativo offerto dal Candura”. Dunque “l’analisi che si è condotta sulla genesi della ‘collaborazione’ con la giustizia del Candura, dell’Andriotta e dello Scarantino – scrivono i giudici – lascia emergere una costante: in tutti e tre i casi, le dichiarazioni da essi rese, radicalmente false nel loro insieme, ricomprendevano alcune circostanze oggettivamente vere, che dovevano essere state suggerite loro dagli inquirenti o da altri funzionari infedeli, i quali, a loro volta, le avevano apprese da ulteriori fonti rimaste occulte”.
Anomalie d’indagine
Ma c’è dell’altro. “Le anomalie nell’attività di indagine – aggiungono i giudici della Corte d’Assise – continuarono anche nel corso della collaborazione dello Scarantino, caratterizzata da una serie impressionante di incongruenze, oscillazioni e ritrattazioni (seguite persino dalla ritrattazione della ritrattazione, e da una nuova ritrattazione successiva alle dichiarazioni dello Spatuzza), che sono state puntualmente descritte nella memoria conclusiva del Pubblico Ministero”.
La Corte ritiene “le indagini successive alla ‘collaborazione’ dello Scarantino furono contrassegnate da numerosi profili del tutto singolari ed anomali. Assolutamente anomala appare, ad esempio, la circostanza che il Dott. Arnaldo La Barbera abbia richiesto dal 4 al 13 luglio 1994 altrettanti colloqui investigativi con lo Scarantino (colloqui che furono autorizzati dal pm Ilda Boccassini, ndr), detenuto presso il carcere di Pianosa, nonostante il fatto che egli già collaborasse con la giustizia”. Altra anomalia si riscontra nelle condotte di alcuni poliziotti appartenenti al “Gruppo Falcone-Borsellino” della Polizia di Stato. Questi “mentre erano addetti alla protezione dello Scarantino nel periodo in cui egli dimorava a San Bartolomeo a Mare con la sua famiglia, dall’ottobre 1994 al maggio 1995, si prestarono ad aiutarlo nello studio dei verbali di interrogatorio, redigendo una serie di appunti che erano chiaramente finalizzati a rimuovere le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni del collaborante, il quale sarebbe stato sottoposto ad esame dibattimentale nei giorni 24 e 25 maggio 1995 nel processo c.d. ‘Borsellino uno'”. E i giudici ravvisano come “tali appunti sono stati riconosciuti come propri dall’Ispettore Fabrizio Mattei, escusso all’udienza del 27 settembre 2013, il quale ha sostenuto di essersi basato sulle indicazioni dello Scarantino. Risulta però del tutto inverosimile che lo Scarantino, da un lato, avesse un tasso di scolarizzazione così basso da necessitare di un aiuto per la scrittura, e, dall’altro, potesse rendersi conto da solo delle contraddizioni suscettibili di inficiare la credibilità delle sue dichiarazioni in sede processuale. A ciò si aggiungono ulteriori aspetti decisamente singolari segnalati da alcune parti civili. Va quindi sottolineata la particolare pervicacia e continuità dell’attività di determinazione dello Scarantino a rendere false dichiarazioni accusatorie, con la elaborazione di una trama complessa che riuscì a trarre in inganno anche i giudici dei primi due processi sulla strage di Via D’Amelio, così producendo drammatiche conseguenze sulla libertà e sulla vita delle persone incolpate”.
La Corte cita anche la lettera che due pm, Ilda Boccassini e Roberto Saieva, avevano scritto ai colleghi per segnalare “l’inattendibilità delle dichiarazioni rese da Scarantino su via d’Amelio”. Una missiva che è stata rinvenuta anni dopo alla Procura di Palermo e non a Caltanissetta.
Partendo da questi fattori la Corte d’assise, senza fare nomi, parla dell’operato dell’autorità giudiziaria. “Questo insieme di fattori – proseguono i giudici riferendosi alla valutazione che venne fatta delle parole di Scarantino – avrebbe logicamente consigliato un atteggiamento di particolare cautela e rigore nella valutazione delle dichiarazioni dello Scarantino, con una minuziosa ricerca di tutti gli elementi di riscontro, positivi o negativi che fossero, secondo le migliori esperienze maturate nel contrasto alla criminalità organizzata”.
Quel che è noto è che non tutti i magistrati condussero dall’inizio quell’inchiesta. Ad esempio l’oggi sostituto procuratore nazionale antimafia Nino Di Matteo, si occupò solo marginalmente delle indagini poi scaturite nel cosiddetto “Borsellino bis”, dove entrò a dibattimento già avviato, mentre istruì completamente il cosiddetto “Borsellino ter”, il troncone dedicato all’accertamento delle responsabilità interne ed esterne a Cosa Nostra. Un processo che ha portato alla definitiva condanna di boss del calibro di Giuseppe Calò, Raffaele Ganci, Michelangelo La Barbera, Cristoforo Cannella, Filippo Graviano, Domenico Ganci, Salvatore Biondo (classe ’55) e Salvatore Biondo (classe ’56).
E proprio nelle conclusioni di quella sentenza, come riporta oggi la Corte d’Assise del “Borsellino quater”, si ritiene “che delle dichiarazioni rese da Vincenzo Scarantino non si debba tenere alcun conto per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle responsabilità in ordine alla strage di via D’Amelio”. Sempre in quella sentenza si scriveva che “risulta quanto meno provato che la morte di Paolo Borsellino non era stata voluta solo per finalità di vendetta e di cautela preventiva, bensì anche per esercitare” una “forte pressione sulla compagine governativa che aveva attuato una linea politica di contrasto alla mafia più intensa che in passato ed indurre coloro che si fossero mostrati disponibili tra i possibili referenti a farsi avanti per trattare un mutamento di quella linea politica. E proprio per agevolare la creazione di nuovi contatti politici occorreva eliminare chi come Borsellino avrebbe scoraggiato qualsiasi tentativo di approccio con Cosa nostra e di arretramento nell’attività di contrasto alla mafia, levandosi a denunciare anche pubblicamente, dall’alto del suo prestigio professionale e della nobiltà del suo impegno civico, ogni cedimento dello Stato o di sue componenti politiche”.
Una trascrizione, quest’ultima, effettuata anche nelle motivazioni della Corte d’Assise che ha evidenziato come di “particolare rilievo” le parole dette da Paolo Borsellino alla moglie Agnese Piraino proprio il giorno prima della strage di Via D’Amelio (“che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo, (…) ma sarebbero stati i suoi colleghi ed altri a permettere che ciò potesse accadere”) e la “drammatica percezione, da parte del Magistrato, dell’esistenza di un ‘colloquio tra la mafia e parti infedeli dello stato'”.
Il movente del delitto e la trattativa
Dunque perché Paolo Borsellino fu ucciso? Il magistrato palermitano “rappresentava un pesantissimo ostacolo alla realizzazione dei disegni criminali non soltanto dell’associazione mafiosa, ma anche di molteplici settori del mondo sociale, dell’economia e della politica compromessi con ‘Cosa Nostra’“.
I giudici, riprendendo le parole scritte dai pm nella memoria conclusiva, affermano che “appare incontestabile come la strage di Via D’Amelio, inserita nella complessiva strategia stragista di cui si è ampiamente riferito, oltre a soddisfare un viscerale istinto vendicativo, si proponesse il fine di “spargere terrore” allo scopo di “destare panico nella popolazione”, di creare una situazione di diffuso allarme che piegasse la resistenza delle Istituzioni, così costringendo gli organi dello Stato a sedere da ‘vinti’ al tavolo della ‘trattativa’ per accettare le condizioni che il Riina ed i suoi sodali intendevano imporre”. Secondo la Corte d’Assise, dunque, nella strage di Via D’Amelio, “era sicuramente riscontrabile la finalità di incutere terrore nella collettività con un’azione criminosa diretta contro Paolo Borsellino per tutto quello che egli rappresentava per la società italiana e volta a destabilizzare pesantemente le istituzioni, scuotendo la fiducia nell’ordinamento costituito. Ne consegue che la finalità terroristica è sicuramente riscontrabile nella strage di Via D’Amelio, la quale non fu soltanto un fatto di mafia, ma un fatto di terrorismo mafioso”.
Convergenza d’interessi
I giudici, che parlano in maniera diretta di “disegno criminoso”, evidenziano come l’occultamento della responsabilità di altri soggetti per la strage di via D’Amelio, nel quadro di una convergenza di interessi tra Cosa nostra e altri centri di potere che percepivano come un pericolo l’opera del magistrato, potrebbe essere proprio uno dei moventi del depistaggio delle indagini. In particolare la Corte ricorda le parole del collaboratore di giustizia Antonino Giuffré: “L’indagine sulle reali finalità del depistaggio non può, poi, prescindere dalla considerazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè, che ha riferito che prima di passare all’attuazione della strategia stragista erano stati effettuati ‘sondaggi’ con ‘persone importanti’ appartenenti al mondo economico e politico”. Giuffrè ha precisato che “questi ‘sondaggi’ si fondavano sulla ‘pericolosità’ di determinati soggetti non solo per l’organizzazione mafiosa ma anche per i suoi legami con ambienti imprenditoriali e politici interessati a convivere e a ‘fare affari’ con essa”.
Il collegamento con l’Agenda Rossa
I giudici mettono nero su bianco per la prima volta che “c’è un collegamento tra il depistaggio e l’occultamento dell’agenda rossa di Paolo Borsellino, sicuramente desumibile dall’identità di uno dei protagonisti di entrambe le vicende”. Il personaggio a cui la Corte d’Assise fa riferimento è Arnaldo La Barbera, funzionario di polizia che coordinò le indagini sull’attentato. Secondo la Corte, ebbe un “ruolo fondamentale nella costruzione delle false collaborazioni con la giustizia ed è stato altresì intensamente coinvolto nella sparizione dell’agenda rossa, come è evidenziato dalla sua reazione, connotata da una inaudita aggressività, nei confronti di Lucia Borsellino, impegnata in una coraggiosa opera di ricerca della verità sulla morte del padre”. Per la corte l’agenda del magistrato, da lui custodita in una borsa e scomparsa dal luogo dell’attentato, “conteneva una serie di appunti di fondamentale rilevanza per la ricostruzione dell’attività da lui svolta nell’ultimo periodo della sua vita, dedicato ad una serie di indagini di estrema delicatezza e alla ricerca della verità sulla strage di Capaci”. La Corte dedica proprio un capitolo alla sparizione dell’agenda rossa evidenziando le “molteplici contraddizioni fra le deposizioni dei vari testi esaminati”. Tra questi anche quella dell’allora capitano Giovanni Arcangioli del Nucleo Operativo Provinciale dei Carabinieri di Palermo. Lui è quel soggetto immortalato nell’atto di allontanarsi dal luogo della strage, proprio in quel disgraziato pomeriggio del 19 luglio, in direzione di via dell’Autonomia Siciliana, con in mano la borsa del magistrato. Un fotogramma che venne fuori soltanto nel 2005 quando il nostro vicedirettore, Lorenzo Baldo, segnalò alla Dia l’esistenza della foto.
Quel che è certo è che oggi sulla strage di via d’Amelio ed i fatti ad essa connessi si continua ad indagare.
La Procura di Caltanissetta ha chiesto il processo nei confronti dei funzionari di polizia Mario Bo e i due sottufficiali Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, accusati di calunnia in concorso. Un’inchiesta coordinata dal procuratote aggiunto Gabriele Paci e dal pm Stefano Luciani.
Intanto la Corte ha ritenuto “doveroso” disporre la trasmissione al Pubblico ministero dei verbali di tutte le udienze dibattimentali in quanto “possono contenere elementi rilevanti per la difficile ma fondamentale opera di ricerca della verità”.
Ci sono ancora diverse zone d’ombra che avvolgono la strage. Misteri irrisolti oltre la sparizione dell’agenda rossa come l‘identità dello sconosciuto uomo che Spatuzza ha detto essere stato presente durante la preparazione dell’autobomba; l’infiltrato di cui parla la mamma del piccolo Giuseppe Di Matteo con il marito nel 1993; le confessioni di Borsellino fatte alla moglie Agnese su Subranni e quelle fatte ai colleghi Massimo Russo e Alessandra Camassa riguardo “un amico che mi ha tradito”. A ventisei anni di distanza, questa sentenza, offre comunque una prima risposta.
01 Luglio 2018


 02 Lug 2018
02 Lug 2018
 Posted by Iskra
Posted by Iskra