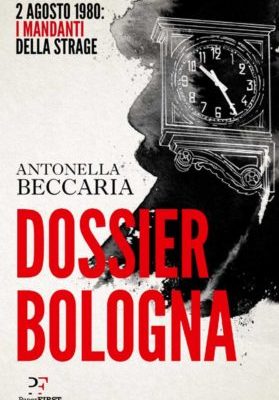![]()
Nel giorno della memoria della strage di Bologna, alle porte di un nuovo processo che possa contribuire a ristabilire la verità su quanto avvenuto in quel tragico 2 agosto 1980, pubblichiamo un estratto del libro di Antonella Beccaria, Dossier Bologna (edito da Paper First), in cui si ricostruiscono i fili di inchieste e processi.
Londra nera
Nel febbraio 1981, tra Firenze e Reggio Emilia, oltre a Da Silva e a Fabbri, nella rete degli inquirenti che indagavano sui furti di mobili finirono diverse altre persone. Tra queste, il fratello di Paolo Bellini, Guido, e un uomo originario di Cossignano, in provincia di Ascoli Piceno, Agostino Vallorani, accusato di ricettazione.
I due negarono di conoscersi, almeno ai tempi, ma è un fatto che nella primavera del 1992, attraverso Vallorani, Bellini conobbe anche un altro personaggio che sarebbe entrato a far parte della sua storia. Si tratta del maresciallo dei Carabinieri Roberto Tempesta che, a cavallo del sequestro di Aldo Moro, da brigadiere ebbe come superiore gerarchico il futuro generale – allora tenente colonnello – Mario Mori, nel 1978 comandante della sezione anticrimine di Roma. Poi Tempesta venne assegnato ad altri incarichi, per approdare al Nucleo Tutela Patrimonio Artistico dell’Arma.
In questa veste, per recuperare cinque dipinti trafugati il 23 gennaio 1992 dalla Pinacoteca Estense di Modena, il sottufficiale si avvalse della collaborazione di Bellini, che, a propria volta, si rivolse ad Antonino Gioè, l’uomo d’onore conosciuto a Sciacca nel 1981 e con cui aveva riallacciato i rapporti nel dicembre 1991. Seguirono l’infiltrazione in Cosa nostra, alcune fasi della trattativa Stato-mafia e le stragi del 1993 a Milano, Firenze e Roma che dovevano avere come obiettivo non più uomini dello Stato, come accaduto un anno prima con gli attentati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma il patrimonio artistico e architettonico.
A questo punto va sottolineato un fatto: nella storia del crimine italiano non era la prima volta in cui si pensò di attaccare le bellezze artistiche. Nel 1974, quando negli ambienti di Ordine Nuovo, disciolto il 21 novembre dell’anno precedente, si discuteva di creare una struttura militare per compiere stragi indiscriminate, il neofascista Massimiliano Fachini propose di attuare «una campagna di attentati contro opere d’arte». La strategia, dunque, sarebbe stata ripresa a quasi vent’anni di distanza.
Ma soffermiamoci su Agostino Vallorani che, nel 1997, nel corso di un’intervista televisiva, affermò: «Sì, la giustizia mi ha davvero rovinato la vita». Oltre alle disavventure giudiziarie con Paolo Bellini, nel corso della sua vita era inciampato altre volte nelle indagini della magistratura. O, meglio, nella sua versione queste erano inciampate in lui.
All’inizio, tutto era filato liscio. Nel 1973, infatti, aveva lasciato San Benedetto del Tronto per trasferirsi a Londra e aprire un negozio di antiquariato che, per qualche anno, si era rivelato un successo. Ma dieci anni dopo il giudice istruttore di Camerino, Alessandro Iacoboni, si era presentato con due carabinieri nella capitale britannica per porgli domande sulla morte di Jeannette May, ex modella ed ex baronessa de Rothschild, scomparsa insieme all’amica e traduttrice Gabriella Guerin il 29 novembre 1980 dopo aver lasciato Sarnano, provincia di Macerata, per dirigersi in montagna.
I loro resti vennero trovati da un cacciatore il 27 gennaio 1982, in condizioni che non consentivano di capire come fossero state uccise. L’omicidio, tuttavia, venne dato per certo. Un omicidio forse legato alla preparazione di una rapina che il giorno dopo la duplice sparizione, il 30 novembre 1980, aveva preso di mira la sede romana della casa d’aste Christie’s, in piazza Navona. Il collegamento nasceva dall’indirizzo capitolino – via Tito Livio 130 – riportato su due telegrammi. Il primo era stato inviato a «Jeanine» May nove giorni dopo la sua scomparsa. Il secondo, invece, era stato recapitato a Christie’s e indicava il luogo dove ritrovare la refurtiva. Curioso notare che in via Tito Livio, ma al civico 76, viveva anche Pippo Calò, il cassiere della mafia trapiantato a Roma.
Ma qual era il collegamento tra la sparizione della donna inglese e Agostino Vallorani, che venne indagato per ricettazione di opere d’arte e poi prosciolto per questa storia? Il trait d’union era un altro antiquario italiano trasferitosi a Londra, Sergio Vaccari, che Vallorani conobbe attraverso un collega fiorentino e che dal 1981 era entrato nella società che gestiva il London Restoration Centre, un’attività spesso in perdita che – si disse – sopravviveva grazie a denaro inviato dall’Italia. Per un po’ condivisero anche un’abitazione in Kensington Park Road affittata loro da Bill Hopkins, un altro antiquario che in quei primi anni Ottanta aveva ingaggiato Roberto Fiore e altri esponenti di Terza Posizione latitanti a Londra per distribuire materiale pubblicitario e guidare minitaxi.
Il nome di Vaccari, a contatto anche con i neri scappati in Gran Bretagna, saltò fuori anche dopo la morte di Roberto Calvi, perché il 17 giugno 1982 sarebbe andato a cena con il presidente del Banco Ambrosiano e sarebbe stato dunque «l’ultimo a vederlo in vita». Nelle prime ore del mattino successivo, infatti, il banchiere era stato trovato impiccato sotto il Ponte dei Frati Neri in quello che per anni venne indicato come suicidio e che poi si rivelò senza dubbio un omicidio, a tutt’oggi irrisolto.
Anche Sergio Vaccari, che in precedenza aveva avuto qualche guaio con la giustizia e aveva dimostrato evidente antipatia per i diritti sociali e dei lavoratori, fu assassinato. Era appena rientrato nel Regno Unito dopo un soggiorno in Italia e poco prima Hopkins lo aveva sfrattato su suggerimento di uno dei suoi uomini di fiducia, avendo saputo che Vaccari forse frequentava ambienti di estrema Destra di cui avrebbero fatto parte due neofascisti coinvolti nella strage di Bologna.
Negli ultimi giorni della sua vita, Vaccari apparve sconvolto e infine, nella serata del 15 settembre 1982, fu aggredito con numerose coltellate nella sua nuova casa londinese, al 68 di Holland Park, nella quale vennero pure trovati due passaporti, uno dei quali britannico intestato a un nome falso, John Max Lloyd. Vaccari, che la sera in cui fu ucciso era in attesa di qualcuno, era stato amico della ex baronessa de Rothschild. Addirittura, dopo la sua morte, in una cassetta di sicurezza riconducibile a lui fu trovata la foto di un orologio che proveniva dal furto subìto da Christie’s a Roma.
Per questo da Camerino gli inquirenti andarono a Londra per parlare con Vallorani. Nella capitale inglese per un altro fatto all’antiquario di Cossignano sarebbe arrivata in primo grado una condanna a un anno e due mesi, annullata poi in appello: si tratta della «rapina del secolo», che il 12 luglio 1987 venne messa a segno al Knightsbridge Deposit Centre di Brompton Road, ritenuto «il [luogo] più sicuro del mondo».
Qui furono svaligiate, con la complicità di un basista interno, cassette di sicurezza e arraffati beni per sessantamila sterline, quasi 130 milioni di lire dell’epoca. A idearla e compierla con alcuni complici era stato il neofascista ascolano Valerio Viccei con un periodo di militanza nei nar e che aveva frequentato camerati legati a Danilo Abbruciati, il boss della banda della Magliana assassinato a Milano il 27 aprile 1982 mentre tentava di uccidere Roberto Rosone, vicepresidente del Banco Ambrosiano.
Vallorani conosceva Viccei dall’infanzia e aveva mantenuto contatti con lui in età adulta, tanto che il primo aveva venduto al secondo un appartamento in Saltram Crescent, sempre a Londra. Ma Viccei era soprattutto colui che nel 1985 aveva iniziato a parlare, tra l’altro, di una strategia di destabilizzazione che, tra il 1973 e il 1974, aveva previsto l’esecuzione di quattro stragi da parte di eversori che, almeno in parte, arrivavano direttamente da Ordine Nuovo e che, dopo lo scioglimento di quel gruppo criminale di estrema Destra, avevano «sviluppato un programma terroristico complementare e parallelo a quello propugnato e realizzato da Ordine Nero».
Conti svizzeri
Il 31 dicembre 1985 Viccei fuggì dal tribunale di Ascoli Piceno e riuscì a scappare in Gran Bretagna, dove si rimise a fare la bella vita fino a quando venne arrestato per la maxi rapina e condannato a ventidue anni di reclusione da scontare nel supercarcere di Parkhurst, sull’isola di Wight. Nel 1992, tuttavia, venne estradato in Italia, destinazione il carcere di Campobasso, e sei anni dopo il colpo milionario iniziò a dire che, nelle cassette di sicurezza di Brompton Road, ci sarebbero stati documenti appartenuti a Calvi.
Tra questi, si ipotizzava che ci fossero un passaporto e una carta d’identità in bianco, oltre a documentazione bancaria della svizzera Ubs. Sarebbe tutto sparito dalla circolazione. Nel colpo, aggiunse Viccei, che fu sentito anche dai pubblici ministeri Andrea Vardaro ed Elisabetta Cesqui che indagavano sulla morte di Calvi, sarebbe stato coinvolto pure Agostino Vallorani, arrestato il 16 settembre 1993. Ma poi, come si diceva, l’assoluzione mise la parola fine anche a questa vicenda.
«L’assoluzione però non mi ha dato certo la tranquillità che avevo prima. Io, quando giro nel mio paese, San Benedetto del Tronto, non sono più famoso perché sono il grande antiquario Vallorani Agostino», disse quando, nel 1997, venne intervistato. Non fece invece alcun riferimento a Roberto Da Silva, a Paolo Bellini e al contatto creato tra questi e il maresciallo Tempesta per recuperare le opere d’arte rubate a Modena. Non parlò nemmeno dell’ambiente che frequentava negli anni più luminosi della sua permanenza a Londra. Dal suo negozio di Ledbury Road, infatti, passava una clientela esclusiva che comprendeva, secondo un testimone del processo per il crac del Banco Ambrosiano, un altro italiano, Marco Ceruti.
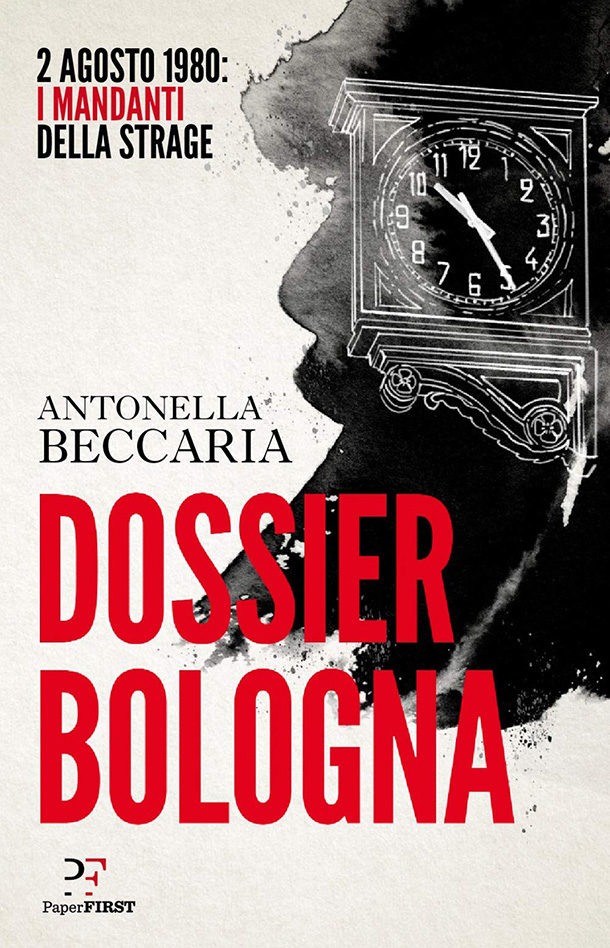 Quest’ultimo, nato a Firenze il 18 agosto 1940, venne descritto come «un bel giovane, alto, simpatico» che aveva iniziato a farsi notare tra il 1974 e il 1975. Dopo aver divorziato dalla prima moglie, si era risposato con una cittadina turca appartenente a una famiglia di prestigiosi gioiellieri. Scelsero una clinica di Londra per la nascita del figlio. Una parte delle attività di Ceruti riguardava il mondo dell’antiquariato mentre nel capoluogo toscano aveva un ristorante ben frequentato, il Doney, o almeno così diceva, dato che non vennero rintracciati documenti che lo attestassero.
Quest’ultimo, nato a Firenze il 18 agosto 1940, venne descritto come «un bel giovane, alto, simpatico» che aveva iniziato a farsi notare tra il 1974 e il 1975. Dopo aver divorziato dalla prima moglie, si era risposato con una cittadina turca appartenente a una famiglia di prestigiosi gioiellieri. Scelsero una clinica di Londra per la nascita del figlio. Una parte delle attività di Ceruti riguardava il mondo dell’antiquariato mentre nel capoluogo toscano aveva un ristorante ben frequentato, il Doney, o almeno così diceva, dato che non vennero rintracciati documenti che lo attestassero.
Qui pranzava spesso un suo amico, il professor Ugo Zilletti, nel periodo in cui era stato presidente dell’Automobil Club cittadino. Anche quando il docente universitario fu nominato vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, i rapporti tra i due risultarono intensi. «Ceruti era in assoluto la persona che più spesso telefonava presso il csm» per parlare con Zilletti.
Quando il 17 marzo 1981 furono scoperte le liste della P2, si scoprì anche una contabile bancaria che recava la data del 14 ottobre 1980 e che li chiamava in causa entrambi. Si trattava del pagamento di ottocentomila dollari. Secondo una nota dattiloscritta che, in seguito, venne attribuita a un tentativo di discredito da parte di Gelli verso l’ormai ex vicepresidente del csm, i destinatari sarebbero stati «Marco Ceruti e Zilletti Ugo» su cui indagò in un primo tempo la procura di Brescia e i cui accertamenti vennero in seguito trasmessi anche alla Commissione P2.
Quando infine le carte arrivarono a Milano, nelle mani degli investigatori che lavoravano sul crac del Banco Ambrosiano, dall’agenda di Gelli emersero sei annotazioni che, tra il 1° giugno e il 20 luglio 1982, avrebbero fatto pensare a un appuntamento o contatti con «Marco», «Zille», oltre che un riferimento a «C. Cassaz.». Negli accertamenti della magistratura, si sostenne che «Ceruti aveva effettivamente una funzione di intermediazione tra Gelli, o chi per lui, e Zilletti». Inoltre si desumeva anche «che Gelli, durante la latitanza prima dell’arresto in Svizzera, ha mantenuto i contatti con i due, probabilmente incontrandosi, in più riprese, con gli stessi».
Fu così che, nella lettura accusatoria dell’appunto trovato nel 1981 a Castiglion Fibocchi, gli ottocentomila dollari sarebbero stati usati per fare pressioni sull’autorità giudiziaria di Milano affinché fosse restituito il passaporto a Roberto Calvi, a cui nel frattempo erano stati contestati reati valutari. Per questo Ceruti e Zilletti vennero indagati a Roma per corruzione, ma a carico del primo doveva esserci qualcosa di più, perché si trovarono tracce di altre transazioni per cifre importanti. Le operazioni finanziarie tra l’antiquario-ristoratore fiorentino e Gelli sarebbero state «riferibili con ogni evidenza a pregressi rapporti, del tutto incompatibili per entità e frequenza con l’immaginata attività corruttrice» per far ottenere al presidente del Banco Ambrosiano documenti validi per l’espatrio.
In effetti, a legare Gelli e Ceruti, non c’erano solo quegli ottocentomila dollari. «Il movimento di denaro […] era ben più consistente, articolato e complesso di quello ipotizzato dagli inquirenti. È risultato infatti che Gelli ha versato a Ceruti in diverse [e] distinte circostanze ingenti somme di denaro». Si poté metterle a fuoco quando il 13 settembre 1982, dopo una latitanza iniziata nella primavera precedente, il venerabile fu arrestato mentre entrava nella sede ginevrina dell’Ubs. Addosso e in una valigetta portava una serie di carte da cui sembrava non separarsi mai e tra queste c’era un importantissimo biglietto, definito «documento Bologna», dall’intestazione – poi scomparsa in copie successive dello stesso documento – in cui si leggeva «Bologna – 52599 – X.S.».
Quando fu analizzato dalla guardia di finanza che indagava sul crac del Banco Ambrosiano, il contenuto di una parte del documento fu chiaro: «Corrisponde a […] un conto corrente acceso presso la Ubs di Ginevra da Licio Gelli». Poiché, invece, all’intestazione, quella in cui compare il riferimento a Bologna, «non si riesce a dare un significato ben preciso», la stranezza morì lì, senza che si indagasse più a fondo né che il documento fosse segnalato alla procura emiliana. In generale, non fu messo in dubbio che si trattasse di una contabile in cui erano riportati date di movimenti bancari, causali, importi, esotici nomi di conti di destinazione e note esplicative, almeno per chi sapeva leggerle. In totale, annotava Gelli nella parte conclusiva del documento, il 12 febbraio 1981 erano stati spostati nove milioni e seicentomila dollari.
Di questi, sei milioni e centomila dollari, al netto di una percentuale destinata a «U. L.», «iniziali di Umberto Ortolani e Licio Gelli», erano giustificati con la causale «Dif. Mi.», «cui è attribuibile il significato “Difesa Milano”». Altri tre milioni e mezzo – sottratta la relativa percentuale – venivano ricondotti a «Dif. Roma». «Restano 1.900.000», da suddividere tra «relaz. Zaff.», ricompensata con ottocentocinquantamila dollari da pagare il 7 ottobre 1980, e «Tedeschi artic.», causale di un pagamento da ventimila dollari che doveva essere disposto il 15 dicembre dello stesso anno.
Quest’ultima parte «potrebbe forse riguardare il parlamentare del msi Mario Tedeschi per motivi non affatto chiari allo stato delle indagini». Ex appartenente della Decima Mas della Repubblica Sociale Italiana, giornalista, direttore del periodico «Il Borghese» e senatore missino fino al 1976, quando si consumò una scissione all’interno del partito, Tedeschi aderì alla comunione massonica di Piazza del Gesù e poi alla P2. Ma negò di aver ricevuto denaro da Gelli o da Umberto Ortolani, mente finanziaria della P2 e dal 1963 gentiluomo del papa. Negò anche di essere stato un giornalista prezzolato in chiave piduista. «Mai Licio Gelli mi ha chiesto di scrivere su qualche vicenda particolare che gli stesse a cuore. D’altra parte le mie idee politiche collimavano con le sue e quindi non aveva bisogno certamente di indirizzare il mio pensiero in direzioni a lui gradite».
Per quanto riguarda l’interpretazione della «relaz. Zaff.», il discorso è più complesso. «Zaff.» o «Zaf.» era una dicitura che tornava spesso negli appunti di Gelli e gli inquirenti, negli anni Ottanta, ritennero che si riferisse alle Fiamme Gialle, cioè alla Guardia di finanza. Peraltro, a testimonianza di un altro rapporto che andava indietro nel tempo, c’era uno spostamento di denaro precedente: 294.117 dollari consegnato il 13 febbraio 1979 a «Zaf “C”», dove «C» – si ipotizzò – avrebbe indicato «comandante» oppure l’iniziale del cognome di un militare corrotto.153 Che percepì denaro almeno in un’altra occasione: «1°/9.6.1979 – Consegnato a Zaf “C”, a mezzo Messaggero Arezzo 506».
«Questo Stato non è un albergo»
In realtà, c’è anche un’altra interpretazione a proposito di «Zaf». Riconduce a Federico Umberto D’Amato, piduista, rimosso nel 1974, dopo la strage di Brescia, dal vertice del famigerato Ufficio Affari Riservati del Viminale e mandato a comandare la Polizia di frontiera, continuando nel frattempo a gestire per conto dell’Italia i rapporti con gli alleati atlantici.
L’Associazione tra i familiari delle vittime della strage del 2 agosto 1980, infatti, a partire dal 2011 aveva inviato in procura una serie di memorie e in una di queste aveva formulato l’ipotesi che D’Amato potesse essere «Zaf», per una ragione precisa: appassionato di gastronomia, aveva scritto ampiamente delle proprietà dello zafferano dicendo di esserne rimasto folgorato dopo una degustazione in Costa Azzurra. Invece la lettera «C» poteva sì indicare la parola «comandante», ma anche «confine», inteso come frontiera, sorvegliato dalla struttura che D’Amato diresse fino al pensionamento, avvenuto nel 1984.
Il conto attraverso cui era transitato il denaro del documento Bologna era contrassegnato da un nome, Bukada, e più in generale si risaliva a una complessa architettura di spostamenti che partivano dal Banco Ambrosiano Andino, passavano per alcune aziende del gruppo – Nordeurope, Utc e Zus – per approdare ai conti di Umberto Ortolani (Noè 2) e di Licio Gelli (Elia 7). Infine, dopo ulteriori passaggi intermedi per altri due conti, ecco che gli importi finivano nella disponibilità di Marco Ceruti che, oltre al conto Bukada, disponeva anche del Tortuga.
Nella perquisizione di Castiglion Fibocchi era stato sequestrato anche un altro appunto manoscritto di Gelli. Da qui si evinceva che a tale «M.C.» – in ipotesi Marco Ceruti – dal 20 luglio al 30 luglio 1980 era stato consegnato un milione di dollari in contanti, il 20 per cento di un importo complessivo di cinque milioni che era stato saldato il 1° settembre successivo.
Ceruti che aveva fatto di tutti quei soldi? Una parte degli importi avrebbe preso la strada di complesse operazioni finanziarie, mentre un’altra – i tre milioni e mezzo inviatigli da Gelli – erano stati «utilizzati con modalità che la documentazione sinora acquisita non consente di chiarire». Da chiarire sarebbe rimasto anche un ultimo appunto del venerabile. Riguardava ancora una volta una dazione di denaro, mille (o più verosimilmente un milione) di dollari che la signora Michelle Agnolini, cittadina svizzera che fu una delle collaboratrici di Gelli, avrebbe dovuto consegnare a «credo cap.», probabilmente «capitano» o comunque un militare. Nel biglietto, l’importo veniva definito un «piccolo acconto» e alla donna venne fornita anche una descrizione del destinatario: «meridionale, biondo, naso largo, cicatrice vicino orecchio sinistro».
Marco Ceruti negò qualsiasi coinvolgimento in questa gotica movimentazione di quattrini e continuò a negare anche quando fu messo di fronte all’evidenza dei fatti. «I miei conti correnti bancari personali sono tutti in Italia in quanto non dispongo di fondi personali all’estero»,160 disse il ristoratore fiorentino, assistito dall’avvocato Maurizio Di Pietropaolo (lo stesso che faceva parte anche del pool che difendeva Gelli), quando nel febbraio 1982 fu sentito dal giudice istruttore di Roma Ernesto Cudillo.
Nonostante tentasse di chiamarsi fuori, Ceruti, ormai definito il «cassiere di Gelli in Svizzera», aveva assunto le caratteristiche di «un punto di congiunzione tra attività di diversi settori che riguardavano attività finanziaria, potere politico, magistratura». Per questo il 22 luglio 1982 fu convocato dalla Commissione P2, ma all’avvio della seduta la presidente Tina Anselmi esordì leggendo un rapporto dei Carabinieri di Firenze che le era stato recapitato poco prima:
Il nucleo di Polizia giudiziaria […] ha fatto conoscere che non è stato possibile citare a comparire quale teste [il] signor Ceruti perché si trova assente dalla sua abitazione […]. Lo stesso nucleo […] ha fatto conoscere che da notizie apprese dall’amministratore dello stabile […] il Ceruti Marco, pur conservando l’appartamento, da circa diciotto mesi si è allontanato per ignota destinazione, molto probabilmente all’estero.
La Commissione ne dispose la ricerca immediata e, se fosse stato rintracciato, l’accompagnamento coattivo a Palazzo San Macuto. Quattro giorni dopo, giunse una nuova relazione dei Carabinieri:
Da informazioni assunte […] presso la questura di Firenze è stato appurato che il signor Marco Ceruti è oggetto, sin dal 19 maggio 1981, di un decreto di ritiro del passaporto […], decreto che non risulta mai revocato o sospeso, e che è stato accompagnato da una segnalazione a tutti i posti di frontiera […]. Peraltro né il decreto di ritiro del passaporto né l’ordine ai posti di frontiera risultano mai eseguiti esistendo agli atti della questura una serie di rapporti, datati maggio-luglio 1981, di ricerche infruttuose del Ceruti in quattro suoi domicili da parte degli agenti incaricati dell’esecuzione”.
Contemporaneamente giunse una memoria dell’avvocato Di Pietropaolo:
Illustre presidente, ho ricevuto alle 10 antimeridiane dal mio cliente […] un telegramma del seguente tenore: “Apprendo soltanto oggi mia convocazione dinanzi Commissione P2. Pregola comunicare presidente Anselmi mia lieve infermità che mi consentirà di presentarmi entro dieci-quindici giorni. Porgo alla Commissione mie scuse per differimento determinato da cause indipendenti la mia volontà, precisando mia totale disponibilità per audizione.
Il legale, ricevuta la comunicazione dal suo cliente, che si sarebbe trovato a Buenos Aires, aveva chiamato la segreteria della Commissione per chiedere che fosse sentito nella prima decade di agosto, prima dell’interruzione estiva. Del resto, aggiungeva, Ceruti non intendeva evitare l’audizione.
Se a qualcosa […] avesse voluto sottrarsi, sarebbe stato il giudizio anticipato e il linciaggio morale della stampa […]. Al signor Ceruti ovviamente non rimane che l’azione contro chi ha organizzato la canea e a lei, signor presidente, che è stimato vigilante delle guarentigie dei cittadini, la ulteriore salvaguardia dei diritti umani e civili di chi, essendo chiamato dinanzi alle massime autorità dello Stato, deve essere posto in condizioni di rispondere con assoluta serenità.
La data dell’audizione venne spostata al 5 agosto. Ma si pose un quesito: com’era stato possibile che un uomo a cui era stato ritirato il passaporto nel 1981 perché sotto indagine a Roma si trovasse un anno dopo in Argentina? Eppure, nel febbraio 1982 in Italia era di certo tornato, dato che si era fatto interrogare proprio nella capitale, e poi era ripartito per l’estero trasferendosi infine in Brasile, dove ottenne la cittadinanza. Qui – fece sapere Ceruti – i commissari potevano raggiungerlo, se avessero voluto, per interrogarlo prima della data convenuta.
«Non è possibile che gli uomini chiave […] abbiano la possibilità di andare e tornare (come se fosse un albergo) dal nostro Paese», sbottò un commissario, una volta ricostruiti i movimenti di Ceruti.
Una risposta ai quesiti della Commissione riguardava un nullaosta concesso al fiorentino per intervento del giudice Cudillo che lo voleva sentire. Quell’autorizzazione aveva inizialmente validità di sei mesi e fu rinnovata per consentirgli di comparire davanti alla Commissione P2, però non prima di settembre. Alla seduta del 5 agosto 1982, infatti, Ceruti non si presentò per i motivi di salute di cui aveva già parlato – specificò di essere affetto da flebite – e che gli avevano impedito di farsi audire a fine luglio.
Intanto, però, sulla questione del passaporto ritirato e dell’andirivieni di Ceruti dall’America Latina era stato sentito anche Federico Umberto D’Amato, il presunto “Zaf ” di Gelli, perché aveva specifica competenza sui confini italiani. Convocato dalla Commissione P2, gli si chiese conto dei quegli spostamenti e D’Amato rispose in modo che venne definito «estremamente evanescente»:
Ho un fascicolo su questo signore, come per tutti coloro che sono segnalati per provvedimenti di frontiera, perché dal mio ufficio dipendono tutti gli uffici di frontiera, con un servizio centrale che si chiama “rubrica di frontiera”. A questa rubrica, che è un volume fisso, che si cambia ogni sei mesi, vengono aggiunte le varianti giorno per giorno, come nel caso di questo signore. Mi chiamai la pratica perché se ne parlava sui giornali. Circa la mancata notificazione [del ritiro del passaporto], vorrei rilevare […] lo ritira la questura, non il mio ufficio. Per quanto riguarda il resto, noi abbiamo sempre trasmesso agli uffici dipendenti le comunicazioni in proposito, ivi compresa la comunicazione che riguarda la revoca del provvedimento per sei mesi; e aggiungo una cosa: siccome ho guardato recentemente la pratica, se non mi sbaglio, ha avuto una proroga di un mese, credo.
A valle di tutta questa storia, l’annotazione accanto al pagamento del 14 ottobre 1980 di Gelli a Zilletti risultava un falso, una manovra del venerabile che aveva dato adito a «un’incauta distorsione nella esatta ricostruzione degli avvenimenti». Dunque, se contro il professore di Diritto romano non era emerso nulla di rilevante, diverso era il discorso per Ceruti, che con il venerabile aveva avuto rapporti pregressi, testimoniati dai movimenti bancari che, direttamente o indirettamente, lo chiamavano in causa fin dal 13 febbraio 1979, quando era stato disposto il primo pagamento a «Zaf».
Gelli, dal canto suo, non aiutò in alcun modo a ricostruire quelle transazioni e non aiutò nemmeno a capire meglio chi si celasse dietro le criptiche diciture che accompagnavano i singoli spostamenti di denaro. Da ormai esperta volpe in grado di muoversi avendo le spalle coperte – «tutte le persone che passavano dalle stanze del suo appartamento al primo piano dell’Excelsior venivano tutte filmate e le conversazioni registrate. […] Diceva che questa era la sua forza» – diede una risposta nel suo pieno stile: «Sono comunque appunti e sigle in codice, difficili da ricordare […]. Non posso ricordare».
Nonostante ciò – ribadirono i magistrati – il passaporto Calvi non aveva a che fare con questa perché già il 25 settembre 1980 aveva riottenuto il documento necessario a consentirgli di partecipare alla riunione del Fondo Monetario Internazionale che si sarebbe tenuta a New York e poi volare a Lima per seguire l’organizzazione di uno sportello di Banco Ambrosiano.
«Quasi dieci milioni di dollari per un passaporto sono sproporzionati, bastavano trecentomila lire», ha ribadito Carlo Calvi, figlio di Roberto, richiamando le conclusioni di Cudillo, e aggiungendo: «A guardare i nomi che ha fatto Ceruti e comparandoli con quelli delle agende di Sergio Vaccari, si vede che sono gli stessi: quelli che facevano parte del gruppo di antiquari che era frequentato da Roberto Fiore e militanti neofascisti».
Peraltro, quando Roberto Calvi riparò a Londra prima di essere ucciso, secondo alcuni informatori, sarebbe stato in fuga da un presunto mandato di cattura che Gelli gli mostrò per la strage di Bologna. «Ora noi sappiamo che effettivamente c’era stata una richiesta del giudice istruttore Aldo Gentile che indagava sulla bomba del 1980 per ottenere l’indirizzo di mio padre e mandargli un mandato di comparizione», ha detto ancora il figlio del presidente del Banco Ambrosiano.
Quando Ceruti si trovò nei guai per il fallimento della banca di Calvi, provò a giustificare gli importi ricevuti da Gelli con l’acquisto – guarda caso – di antichità a Londra per conto del venerabile. Ma l’affermazione, nel 1992, venne smentita da alcuni dirigenti della Merlin Writers, una società di Jersey che schermava le attività finanziarie dei suoi clienti e che in precedenza aveva documentato la vendita all’imputato di oggetti d’arte pagati in contanti vari miliardi di lire.
In un primo tempo sembrarono attestarlo anche degli affidavit dattiloscritti risalenti al 1981,180 ma che, alla prova dei fatti, risultarono redatti nel 1987 non con una macchina da scrivere, ma con un computer. A processo, un manager sostenne inoltre di aver ceduto, insieme ai colleghi, alla richiesta di Ceruti che aveva necessità di crearsi un alibi, attribuito alla bancarotta fraudolenta dell’Ambrosiano. Infatti, «a un certo punto l’accusa di Milano ha seguito questa linea: Ceruti era una persona che aveva contribuito al dissesto della banca di mio padre. Avrà pure contribuito, ma in realtà era responsabile di cose ben peggiori».
Infine c’è un’ultima circostanza a cui vale la pena accennare e che unisce personaggi legati alla strage di Bologna – il generale Pietro Musumeci e il colonnello Giuseppe Belmonte, condannati per i depistaggi alle indagini sull’esplosione alla stazione – con la storia del Banco Ambrosiano. Nel 1981, in corrispondenza della trattativa per la liberazione dell’assessore campano Cirillo, ai due ufficiali del Sismi vennero affidate alcune consulenze per un nuovo (o rinnovato) piano della sicurezza del Banco, malgrado ne esistesse già uno. «Erano consulenze abnormi. Non sappiamo chi le avesse spinte e incontrarono una notevole opposizione interna», ha detto il figlio di Roberto Calvi, Carlo. Nonostante le contrarietà dentro il Banco Ambrosiano, però, vennero comunque assegnate, dando un notevole potere ai due uomini del servizio segreto militare.
Non si sarebbe trattato – o non si sarebbe trattato soltanto – di un sistema per intascare parecchi quattrini in modo semplice. «A quell’epoca si davano soldi a tutti senza troppa discrezione». Di cosa si trattava, allora?
Era una mossa concertata più per introdurre un elemento ulteriore di infiltrazione all’interno del funzionamento del Banco perché i vari gruppi contrapposti, che facessero capo a Flavio Carboni o a Francesco Pazienza, si erano resi conto che mio padre era il presidente, ma non decideva tutto. Lo scopo era dunque avere un elemento maggiore di infiltrazione nel processo decisionale interno. Molte persone interne, come il vicepresidente Rosone, erano in contatto con persone esterne che volevano in qualche modo sapere cosa succedeva nel Banco.
Tra queste persone, interessate alle informazioni che Musumeci e Belmonte avrebbero potuto raccogliere, ci poteva essere il giornalista missino Mario Tedeschi, che aveva «un canale diretto con Rosone».
02 Agosto 2020


 06 Ago 2020
06 Ago 2020
 Posted by Iskra
Posted by Iskra